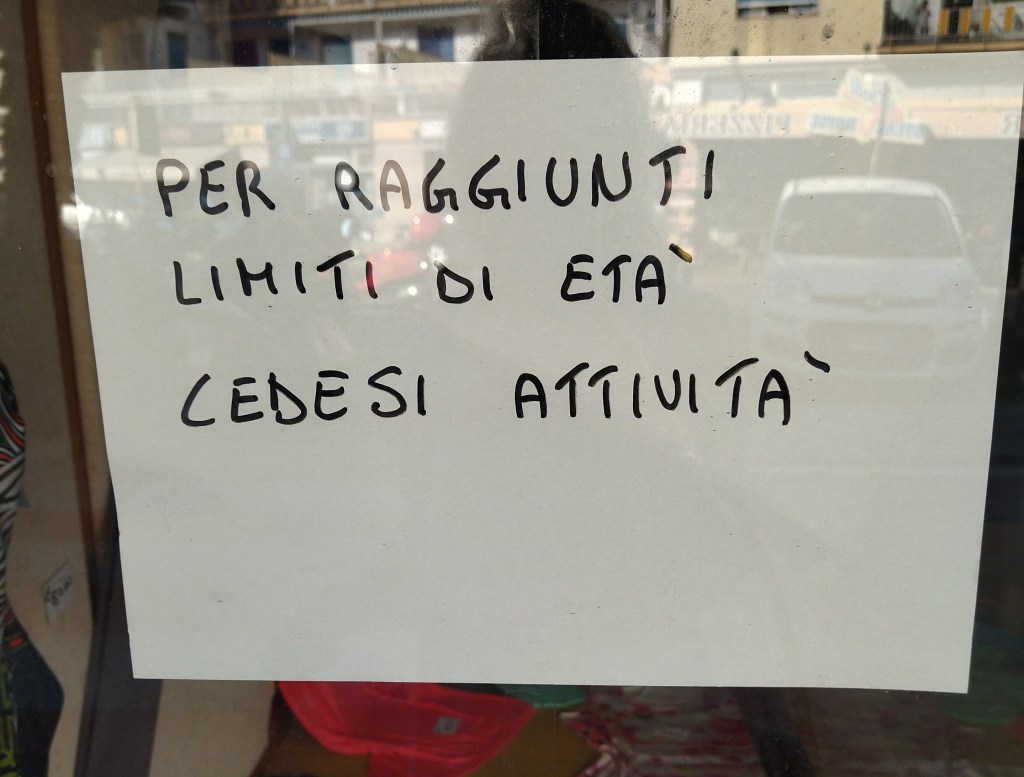Ti diranno che è colpa della tua laurea, perché non sottolinea quanto tu hai studiato ma evidenzia quanto gli altri non hanno studiato e che comunque anche con la terza media hanno più cuore di te e sono buoni. Spiegherai che non è pertinente come osservazione, non ci azzecca un cazzo di niente la laurea con la bontà di cuore.
Ti diranno che dici troppe parolacce. Spiegherai che c’è una qualche ricerca di una qualche Università (ecco, vedi) di un qualche Stato degli Usa che ha dimostrato che chi ricorre al turpiloquio (cioè dice tante parolacce) è più intelligente di chi non lo fa. E non importa se chi non lo fa è più buono. Proprio non importa. Avete rotto il cazzo con la bontà.
Ti diranno che devi prendere gli altri per quello che sono, che gli altri “sono fatti così”. Spiegherai che anche tu sei fatta così. Ti diranno che, per te, varrà di meno la validità dell’assunto “sono fatto così”. Spiegherai che non hai più voglia di prendere gli altri, perché si prendono le medicine e tu stai benissimo. Che le persone non sono particolari come raccontano di essere ma molto meno, tu per prima. Si può non avere più voglia. E tu non hai più voglia.
Ti diranno che è colpa della psicoterapia se stai male. Del tuo carattere difficile. Del tuo cinismo. E, comunque, non hai motivi di stare male. Non veri. È colpa del fatto che ricordi tutto, ecco. Non è che stai male ma vivi male perché hai questo problema, sommato al cinismo, al carattere difficile, all’assenza di ogni forma di compassione: ti ricordi tutto. Ti batterai una mano sulla fronte e spiegherai che ti sei dimenticata che ricordi tutto, ecco il problema, è vero. Grazie, grazie, per avermelo ricordato, dirai tra lo stupito e il commosso. Grazie. Fine della terapia, a chi serve la terapia? In effetti basta guardarvi per vedere come avete elaborato bene, da soli, i lutti, gestito gli abbandoni e superato le infanzie di merda che avete sulla gobba. Fine del Lupo che vive dietro lo sterno e che mi incatena in quei giorni in cui non si può vivere, fine del cinismo e del carattere difficile, grazie. Per la compassione invece, niente. Mi dispiace. Anzi, no.
Ti diranno che non hai pazienza. Spiegherai che è così. Confesserai che è così. Non hai pazienza ogni volta che aspetti in fila senza mai saltare la coda. Non hai pazienza ogni volta che aspetti il tuo turno per parlare, mangiare o pisciare. Non hai pazienza quando aspetti che il semaforo diventi verde anche se non ci sono auto e tu sei l’unico pedone che aspetta il verde e se ne trovi un altro potrebbe solo trattarsi di Kant redivivo, non hai pazienza quando parcheggi a tre isolati pur di farlo bene e non recare disturbo. Spiegherai che è vero, questa non è pazienza. Questo è saper aspettare. Questo è non prevaricare. Sono beni succedanei della pazienza, della quale sei sprovvista, quel che ti è sufficiente per non spaccare la testa a qualcuno o non sbraitare libera come sono liberi i pazzi in mezzo alla strada. Farai spallucce. Pace.
Ti diranno che devi lavorarci su. Sui tuoi difetti. Ti devi mettere sopra e lavorarci su. Possibilmente eliminarli o silenziarli o renderli innocui o almeno fare in modo che non si vedano. Si fa così con i difetti. È la regola, lo sanno tutti, anche quelli che non hanno la laurea e che comunque sono buoni e quindi difetti ne hanno pochi e non devo lavorarci su, possono continuare a fare altro, magari più giù. Spiegherai che, in effetti, quando qualcuno ti invita a lavorare su qualcosa di te (siamo tutti d’accordo che i difetti sono qualcosa di noi, vero?) ti sta raccontando una sua esigenza e non una tua necessità. Spiegherai che ti sei arrampicata su ogni tuo difetto per metterlo in sicurezza, perché non facesse male a te o agli altri e poi ti ci sei avvinta intorno e lì stai, lì sei davvero.
Ti diranno che sei forte. Spiegherai che non è vero, semplicemente non ti lamenti.
Ti diranno che comunque non hai nulla di cui lamentarti e a suffragio di ciò ti forniranno un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle benedizioni che inondano la tua vita: hai una bella famiglia, sana, Lui ti ama, le ragazze sono brave (forse non buone, ecco, va detto perché sono troppo studiose, e comunque potrebbero rivelarsi meglio di te, già lo hanno fatto), hai una bella casa, un buon lavoro, vai in vacanza e a cena fuori, frequenti teatri e quel minimo di eventi culturali della tua città che corroborano la tua autopercezione di donna intelligente. Spiegherai, tormentando il rubino alla mano destra, che, come dicevi, non ti lamenti proprio di niente. E fornirai un elenco esaustivo e non esemplificativo dei motivi che ti hanno portata ad avere le benedizioni che inondano la tua vita: un gran lavoro dalla mattina alla sera e certe volte dalla sera alla mattina, qualche compromesso buttato giù con un calice di Chablis perché lo Champagne ti provoca mal di testa, un’organizzazione di tempi e spazi e metodi che potresti brevettare e diventarci ricca ma non lo fai perché non sei avida, la curiosità di non smettere mai di imparare. Di impararti.
Ti diranno che la tua scrivania è troppo piena, spiegherai che si tratta del riflesso della tua mente. Inviterai a guardare le scrivanie, sgombre, di altri collaboratori.
Ti diranno che sei una bella donna, ancora. Che porti bene i tuoi anni. Spiegherai che sono i danni, che porti bene. Ma il gioco di parole è troppo facile, quasi banale, ti pentirai subito dopo averci giocato. Assumerai un’aria malinconica e questo non ti viene mai difficile, un comico quando il pubblico ride tranne uno seduto in fondo, solo uno, un clown nell’atto di indossare le scarpe di scena, un bambino quando lo chiamano che è ora di andare, un’adolescente che aspetta per ore qualcuno che non si presenterà all’appuntamento. Dondolerai la testa bionda, passerai le dita all’attaccatura dei capelli, dietro, appena sopra il collo, a seconda del periodo potrebbe restarti qualche filo sottile incastrato tra gli anelli. Spiegherai che hai l’età di tua nonna quando sei nata e che sei rimasta a lungo incantata a guardare la sua di bellezza, così leggera e non malinconica, la guardavi di nascosto, mentre ripassava il rossetto davanti allo specchio del suo bagno, e tu restavi appoggiata allo stipite, un po’ girata, un po’ distratta ma per finta, mentre cambiava le marce della sua auto che aveva il cambio attaccato al volante e non in mezzo ai sedili come la macchina di tuo padre, e intanto cantava e diceva un sacco di parolacce agli altri automobilisti e tu restavi ferma sul sedile accanto, a tenere i sacchetti del pane e della verdura e di qualche scampolo di stoffa per farci qualcosa chissà cosa ma con quelle mani poteva fare tutto, sfilava il rubino e lo poggiava sul comò, indossava una vestaglia che annodava in vita, il seno sobbalzava a ogni passo, con la mano destra si chiudeva un po’ davanti, ogni tanto, come un intercalare. Spiegherai che è questa la bellezza. Non è essere bella ancora, ma essere àncora bella, così da tener salda l’imbarcazione quando è tempo di stare fermi, in porto. Così da poter levare via ogni peso e lasciare che si possa salpare, quando il tempo è buono e l’equipaggio pronto. Ma il gioco di parole non è semplice, ci penserai subito dopo averci giocato. Ti commuoverai e questo non ti viene mai facile, un ricordo di soppiatto, la zampa del cane che ti ferma la mano sul tavolo del veterinario, un’amica che vuole solo sapere come stai.
Ti diranno che devi essere felice. Spiegherai che è una buona idea, peccato non averla avuta prima e autonomamente. Ti diranno che comunque se non sei felice è solo colpa tua. Spiegherai che il mondo si divide tra chi ha sempre colpa e chi ha sempre merito. O chi ha sempre fame e chi ha sempre sonno. O tra chi dice e chi spiega. E, sì, tu sei una colpevole, sonnolente, spiegazzata persona.
Ti diranno che bisogna avere figli, fare figli, perché colmano un vuoto. Spiegherai che sono i figli che lo creano quel vuoto, che prima dei figli non c’è alcun vuoto, è tutto pieno a volte riempito, va bene, non importa. Prima dei figli c’è tempo e c’è spazio, che poi sono le dimensioni che più ci riguardano. E il tempo è pieno e lo spazio anche. Dopo i figli scoprirai il vuoto. Quando? Non si sa. È come la scoperta dell’inesistenza di Babbo Natale, ciascuno a suo modo. Potrebbe capitare a una stazione dei Flixbus, quando resti in disparte perché lei è troppo assorta in una conversazione che non ti riguarda, tu dovevi solo portarla lì, non sei tra i compagni di viaggio, non arriverai a Bergamo, non salirai sull’aereo dopo aver imbarcato il bagaglio in stiva e svuotato la bottiglietta d’acqua prima dei controlli. Tu puoi portare i cani a fare la pipì lì intorno, finché non parte il bus almeno. Potrebbe capitare davanti a un display che indica un ritardo di mezz’ora nell’atterraggio, potresti trovarti a immaginarla sopra di te, in aria, né qui né lì e anche se sai che non è atterrato perché è scritto, sorridi ogni volta che si apre la porta scorrevole e qualcuno appare con i suoi bagagli e si guarda intorno, non sei lì per loro, loro non aspettano di trovare te. È nata in ritardo, pensi. Vorresti raccontarlo a qualcuno ma non c’è nessuno a cui interessi. Devi solo riempire un vuoto che prima non avevi e adesso hai ogni volta che si staccano, ehi, qui avevo una figlia e adesso è vuoto, dove? Qui, lungo il fianco, a portata di mano. Qui, con le gambe a cavalcioni sul mio bacino, qui sulle ginocchia, qui, in auto a subire i silenzi del mattino quando è troppo presto per tutto tranne che per ascoltare musica di merda. Ehi, avevo una figlia e adesso è vuoto, dove? Qui, mentre lavoro in ufficio e ascolto la lezione di scienze, qui mentre andiamo dal dentista, dall’oculista, dall’ortopedico, dal fisioterapista, dall’estetista. È nata in ritardo, la immaginavi dentro di te, nell’acqua, né qui né lì e poi è arrivata e non c’era più spazio e più tempo e poi se n’è andata ed ecco quanto spazio e quanto tempo. Il tuo vuoto è il suo pieno, la vita in cui tu non ci sei non risente della tua assenza, tu resti congelata, da sbrinare quando servi. Ti sembra di averlo già percepito, in un’altra era della tua vita, ti sembra di averlo già vissuto ma non proprio così, più al rovescio, più da un altro punto di vista, quello di chi sta partendo e dopo aver salutato non si gira, perché è certo di quel che c’è dietro, di chi c’è dietro. Potrebbe capitare davanti al display che segnala l’atterraggio e si potrebbe, persino capire, profondamente capire, che non sei più tu a partire, tu sei quella che aspetta e che è meglio farlo sorridendo, così chi torna ti troverà àncora bella.

Di àncore belle, abitini spiegazzati e anticorpi casalinghi.